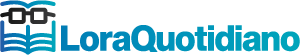Da noi la palla di riso fritta è oggetto fecondo, deputato a sedurre, tentare, figliare. E’ maschio nel messinese, e altrove, ma non qui. Con buona pace di Andrea Camilleri, che ha imposto ovunque la sua lettura della pietanza come voleva e poteva, mettendo in un titolo e sotto il naso del suo Montalbano “gli aranci-ni”.
“C’è tutto dentro, è come uno zaino: lei se lo porta appresso per un mese e sta sicuro…”. Così, nel film “Bianca”, Nanni Moretti descriveva il cannolo siciliano a un attonito commissario di polizia. Energia e dolcezza in grado di sopportare le temperie della vita. Dessert bastante a se stesso, lussureggiante e fedele, anche da viaggio e, all’occorrenza, da nascondere come un tesoro.
Vedeva lungo. Noi siciliani siamo così: ci piace avere il mondo in mano. Più per paura che per hinkeliana megalomania. L’arancina – non solo quella del 13 dicembre, ricorrenza che la lega a S. Lucia – non sfugge alla regola. C’è il tutto dentro, racchiuso nella sua crosta e, ora che ci rifletto, somiglia davvero al mondo. Rotonda, fragrante all’esterno e ricca – d’una magmatica, misteriosa abbondanza – all’interno.
Aranci-na. Con la “a”. Ci teniamo così tanto a questa specie di globo terrestre – talmente ci somiglia – da farci battagliare per difenderne la femminilità. Arancina, non arancino. Arancine: mai arancini. Almeno nel palermitano. Da noi la palla di riso fritta è oggetto fecondo, deputato a sedurre, tentare, figliare. E’ maschio nel messinese, e altrove, d’accordo, ma non qui. Con buona pace di Andrea Camilleri, che ha imposto ovunque la sua lettura della pietanza come voleva e poteva, mettendo in un titolo e sotto il naso del suo Montalbano “gli aranci-ni”.
Discussa è pure l’origine dell’arancina. Ecco su che cosa siamo capaci di argomentare, a queste latitudini. Per qualcuno sarebbe il frutto di un antico esperimento culinario andato a male: il tentativo dello chef di un nostro re di “là fuori” (abbiamo sempre avuto un qualche re di “là fuori”, a Palermo) che provò a fare il risotto alla milanese (pardon: “dei milanisi”) per il sovrano, fallì e si ritrovò a salvare il salvabile arrangiandolo in sfera di riso panata e tuffata nell’olio. Per altri, l’arancina c’è sempre stata. Rotolò fino a noi dal regno di un Dio annoiato, e c’è poco da aggiungere: mangia e “più non dimandare”.
Ciascuno di noi, d’altronde, ha un’intima concezione dell’arancina. Proprio come la abbiamo del mondo. Non mi resta che raccontarvi la mia.
Per me, tra il 1970 e i primi anni Ottanta non è esistita altra arancina che quella del signor Di Blasi, un tizio di Ballarò dalle sopracciglia cespugliose e abbigliato con una canottiera perenne, indifferente alle stagioni. Dalla sua vetrinetta poggiata su un piano di fòrmica, Di Blasi faceva carambolare fino al cliente – dribblando montagnole di “rascatura” e pianori di “felle” – la sua arancina “in bianco”. Dentro: “capuliato” grigio pallido, soffritto nella cipolla e sfumato col vino. “Bellissima”, direbbe uno di Ballarò. Leggasi: “Buona”. Al Di Blasi s’aggiungeva poi un ambulante in bicicletta il quale, sul far dell’inverno, passava dalla vendita dei gelati a quella delle arancine, ma in una differente incarnazione. “Che-do-cce!”, era il grido di battaglia dell’ometto su due ruote. Fu per suo merito che io scoprii l’esistenza delle arancine al cioccolato. Dolci (o meglio: “do-cci”). Confesso: non le ho mai assaggiate. Nella vita, come nelle palle di riso, preferisco il salato.
Assodato a questo punto che l’arancina è un prodotto quasi cosmico, ispirato al globo terrestre, oppure alla luna, eccone il lato oscuro e maledetto: le famigerate arancine del traghetto. Ci spostiamo a Messina, sullo stretto, abbiamo messo piede sulla Caronte e… sono davvero in pochi a non aver addentato le arancine di bordo schivando il contrappasso: un’acidità di stomaco memorabile, difficile da esperire in altre occasioni. Abbiamo così sconfinato nel campo della leggenda cupa, e si potrebbe anche divagare sulle dicerie metropolitane che circondano, in negativo e in positivo, le “case dell’arancina”, celebri per tradizione, che costellano la città. C’è chi, tra gli “arancinari” storici, quelle grosse biglie di riso continua a farle buonissime; chi è peggiorato; chi le cucina con alterne fortune; chi… “la finanza ci ha trovato i colibatteri fecali”; chi, una volta scivolato sull’unto, si è riabilitato; chi non è imbattibile: “Altro che il tal dei tali a piazza…” (e sui nomi dei rivenditori si aprono scommesse).
Ma mettiamo un punto o non ne usciamo più. Andiamo all’oggi. Il mondo cambia pur essendo incardinato nella sua immutabile orbita. Così le arancine. E’ nata, da non molto, l’arancina “fai da te”. L’avventore mette piede in un negozio essenziale e pulitissimo (il signor Di Blasi è ormai un fantasma lontano, sebbene viva e frigga ancora nella mia mente) e si ritrova davanti all’ira di Dio di arancine dai gusti inaspettati, al friarello, al chili messicano, tradizionale, “a-bburro”, “a-ccarne” (mai dire a un palermitano “al” burro e “con” la carne: equivarrebbe a dirgli “aranci-ni” invece che “aranci-ne”). Poi si può anche ottenere la combinazione che più aggrada. E’ un’idea. I ragazzi della “nouvelle arancina” hanno guardato all’arancina-mondo con attenzione, umiltà, si sono chiesti come invertirne il girotondo e hanno scoperto l’uovo di Colombo. Anche grazie a loro – citando Jimmy Fontana – il mondo non si fermerà mai un momento. E l’arancina nemmeno.
© Riproduzione riservata